Sinossi
L’amore per una donna è il tema che più di ogni altro impegna i poeti italiani dal Duecento al tardo Cinquecento, e il fenomeno non ha corrispettivi nelle culture affini alla nostra. A cosa sarà dovuto tanto successo? Questo studio offre una spiegazione: i trovatori provenzali legarono l’amore erotico ad una problematica morale, e gli italiani, a cominciare dai poeti della scuola siciliana, conservarono questo legame ma lo problematizzarono in modo nuovo, e lo stesso accadde con i poeti siculo-toscani, con gli stilnovisti e persino con Dante, nei quali l’amore diventa un problema scientifico e filosofico e teologico. Ma enfin Pétrarque vint, e impostò la storia del suo amore come un “esercizio spirituale”, scoprendo la coscienza e la volontà come fattori indispensabili in una lotta eroica verso la saggezza e poi verso la salus eterna.
E fu il modello che conquistò generazioni di poeti “eroi” dell’amore. Questi a loro volta apportarono delle varianti: nel ’400, la poesia diventò fonte di “fama”, e nel ’500 spingeva a contemplare la bellezza divina. Nel frattempo emerse l’eros naturale e indispensabile nell’amore. Marino scrive una “canzone dei baci”, e l’Adone è un poema incentrato sull’amore erotico: muore così il legame dell’amore con la morale, e ne nasce uno nuovo che lega l’amore venereo all’estetica.
Formati disponibili

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.
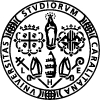 UNICApress
UNICApress
